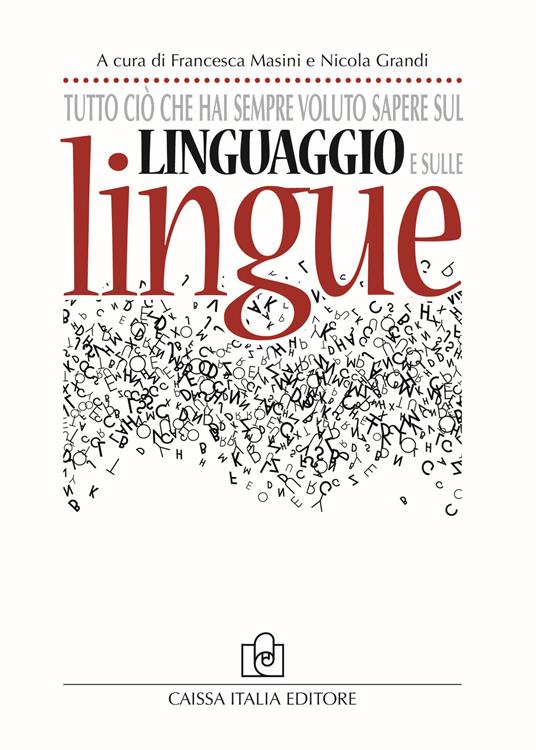Ecco una lista di letture per chi vuole aumentare la propria consapevolezza sulla lingua (nostra e di altri paesi)
La consapevolezza linguistica non si sviluppa da sola, ma ha bisogno di stimoli continui e di molta curiosità. I libri sulle lingue sono senza dubbio un ottimo carburante per un’accelerata in questo senso. Ne esistono moltissimi, ma noi qui abbiamo voluto fare una piccola selezione fra quelli più recenti, includendo titoli adatti a tutti.
Attenzione: non sono solo testi di linguistica in senso stretto, ma abbracciano anche punti di vista diversi, come quello filosofico (esiste, e ha una nobile tradizione accademica, la filosofia del linguaggio), sociologico e antropologico.
1. Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sul linguaggio e sulle lingue (Caissa Italia Editore)
Titolo ambizioso per uno dei volumi che più ha contribuito alla divulgazione linguistica negli ultimi anni, curato da Francesca Masini e Nicola Grandi e vincitore, non a caso, del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica nel 2017.
I curatori muovono da una constatazione non superflua: «lingua e linguaggio: li usiamo in maniera automatica e intuitiva. Ma quali sono i meccanismi che li fanno funzionare?». Per scoprirlo, Masini e Grandi hanno chiesto a 39 linguisti italiani di rispondere alle domande più frequenti sulla lingua e sul linguaggio.
2. Babele (Garzanti)
Un librone dallo stile molto avvincente nel quale il giornalista-linguista poliglotta Gaston Dorren ci porta alla scoperta della ricchezza delle lingue del mondo attraverso le venti che, se conosciute e parlate, ci permetterebbero di comunicare con tre quarti degli esseri umani.
Lingue franche note come l’inglese, il francese e lo spagnolo, ma anche sistemi linguistici meno pop, come il malese e il bengalese. Questo libro trasferisce molte informazioni e curiosità, ma senza mai appesantire il lettore. Adatto proprio a tutti, anche a coloro che di lingue (e di linguistica) non ne sanno praticamente nulla.
3. Che cos’è la linguistica (Carocci)
Questo testo, sebbene abbia un taglio più accademico, è un ottimo punto di partenza per avvicinarsi in modo serio alla linguistica. L’autore, Gaetano Berruto, è uno dei più apprezzati (socio)linguisti italiani e ci porta alla scoperta della disciplina che studia il linguaggio da un punto di vista scientifico, introducendoci ai principali livelli di analisi che lo riguardano.
Un testo impegnativo senza dubbio, consigliato a chi vuole addentrarsi davvero nei meccanismi che governano le lingue. Per maggiori dettagli potete consultare questo nostro articolo.
4. La verità sul linguaggio (per quel che ne so) (Carocci)
Anche questo volume di Michael Corballis, professore emerito di Psicologia all’Università di Auckland, ha un titolo decisamente ambizioso e presuppone qualche conoscenza di linguistica generale (meglio quindi affrontarlo dopo aver letto il testo al punto 3). L’autore cerca di fare il punto fra le teorie sull’origine del linguaggio per rispondere a una domanda che stuzzica la curiosità di molti: che cos’è e come è nato il linguaggio?
La tesi sostenuta da Corballis non ha niente a che vedere con big bang cognitivi o improvvise comparse di questa che è la facoltà che più ci distingue dagli altri esseri viventi («Naturalmente, anche gli altri animali comunicano, ma le loro forme di comunicazione non hanno niente a che vedere con la grandezza del linguaggio umano» scrive Corballis nella prefazione al libro). Per l’autore, semmai, lo sviluppo del linguaggio umano è da attribuire a graduali modificazioni dalla lunga storia evolutiva.
5. La lingua che cambia (Eris Edizioni)
Questo breve saggio di Manuela Manera accompagna chi legge attraverso una serie di riflessioni sugli usi che facciamo della lingua, mettendo in luce abitudini sessiste e illustrando come la battaglia per l’allargamento dei diritti civili non sia disgiunta da scelte linguistiche consapevoli.
Con uno stile discorsivo, questo breve ma denso libro ci spinge a interrogarci sulla nostra comfort zone linguistica: come abitiamo noi la lingua? Che uso facciamo delle parole? Come rappresentiamo le persone attraverso le nostre comunicazioni? Cos’è il cosiddetto “linguaggio inclusivo”?
6. Le basi proprio della grammatica (Bompiani)
Titolo provocatorio per un testo che vuole aumentare la consapevolezza grammaticale di chi lo acquista, nel solco del «non lo sapevo» e del «pensavo X e invece è Y». Come recita scherzosamente il sottotitolo, si tratta di un Manuale di italiano per italiani, o per lo meno per tutti quelli che desiderano liberarsi di alcuni dubbi ricorrenti sulla forma di ciò che scrivono e dicono. Lo stile di Manolo Trinci è irriverente e accattivante, lontano dai formalismi, spesso inutili, dei testi di grammatica a cui ci siamo abituati a scuola.
7. Grammatica del nuovo mondo (Lupetti)
Nonostante il titolo suggerisca un contenuto di tipo morfologico, questo libro del giornalista Filippo Poletti è dedicato principalmente al lessico: raccoglie 50 termini che incarnano i cambiamenti avvenuti nel periodo pandemico. Un lavoro che nasce da un’accurata raccolta di informazioni – oltre 600 sono le note in relazione ad articoli di cronaca – e svolto da una delle Top Voice di LinkedIn più autorevoli per quanto riguarda i temi del lavoro. Un testo per coloro che vogliono guardare all’attualità con uno sguardo più consapevole da un punto di vista lessicale.
8. Che cos’è la linguistica clinica (Carocci)
Il nostro linguaggio può non funzionare come quello della maggior parte delle altre persone: a causa di un trauma (fisico o psicologico), per una patologia (pensiamo a quelle mentali, come l’ansia o la depressione) o infine per una neurodiversità. Ecco, c’è una sottodisciplina della linguistica che applica teorie e metodi linguistici all’analisi e al trattamento dei disturbi della lingua parlata, scritta e segnata; ce la presenta Gloria Gagliardi in questa bussola di Carocci.
9. Le ragioni del dubbio (Einaudi)
Sempre più spesso, soprattutto ma non solo sui social network, scriviamo e parliamo senza prima pensare, neanche un attimo. Da questa constatazione muove il ragionamento dell’ultimo libro di Vera Gheno per Einaudi. E poiché le parole quasi mai sono dei semplici segni grafici o una stringa di suoni assemblati fra loro, ciò che diciamo e scriviamo custodisce pezzi significativi della nostra visione della realtà e delle nostre certezze. Non sorprende così che le parole «possano generare conflitti e fare male. Ma possono anche generare empatia e fare del bene, se impariamo a usarle meglio».
Gheno propone un metodo per farlo, basato innanzitutto sui dubbi che dovremmo considerare prima di produrre un enunciato, ma anche sulla «riflessione, che deve accompagnarci ogni volta che formuliamo un concetto. E infine sul silenzio, perché talvolta può anche succedere, dopo aver dubitato e meditato, che si decida saggiamente di non avere nulla da dire».
10. Abbecedario del postumanismo (Mimesis Edizioni)
Dalla A di Accelerazionismo alla Z di Zootecnia, questo abbecedario, curato da Elisa Baioni, Lidia Marìa Cuadrado Payeras e Manuela Macelloni, accoglie i contributi di alcuni dei più importanti esponenti del pensiero postumanista, che provano a sillabarne le parole chiave allo scopo di mettere ordine in questo vasto universo e, soprattutto, di ridefinire e attualizzare alcuni termini che ci sono stati consegnati dalla società umanista.
Anche questo testo affronta, quindi, i cambiamenti in atto nel mondo contemporaneo ma da un punto di vista filosofico, antropologico e sociologico, abbracciando temi come il rapporto tra uomo e digitale, il cambiamento climatico e la sesta estinzione di massa.